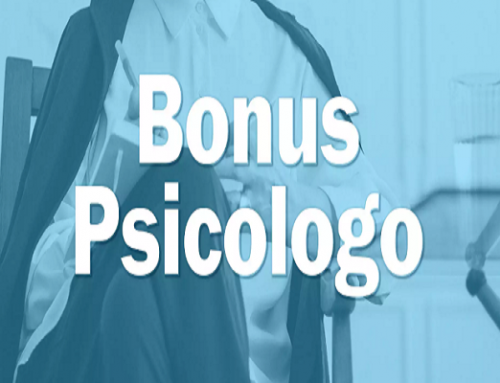Per affrontare il tema della violenza di genere, dal mio punto di vista, si deve partire dai numerosi pregiudizi che avvolgono la questione. Siamo ingiustamente abituati, per esempio, a credere che gli episodi di violenza siano circostanziati a particolari realtà disagiate, chiuse: extracomunitari rabbiosi e un po’ barbari? Ragazzi sbandati delle periferie? Malati di mente, tossicodipendenti, personaggi al limite della società? No: questi sono stereotipi sbagliati e pericolosi, e sono sbagliati e pericolosi perché impediscono di raccontare, affrontare e combattere la tragedia della violenza contro le donne.
Chi colpisce?
Dai dati del 2019 forniti della Polizia di Stato emerge che vittime e carnefici sono, inoltre, per lo più italiani: le prime nell’80,2% dei casi, i responsabili nel 74% dei casi. È stato confermato che l’82% delle volte chi fa violenza su una donna, è un volto amico: o il compagno o un conoscente. In aumento il numero dei femminicidi passati dal 37% del 2018 al 49% tra gennaio ed agosto 2019. Il 67% di queste vittime è straniero, e anche qui nel 61% dei casi l’autore è il partner. Praticamente ogni 72 ore in Italia una donna viene uccisa da una persona di sua conoscenza, solitamente il suo partner; tre su quattro avvengono in casa; il 63% degli stupri è commesso da un partner o ex partner. La violenza sembra non avere passaporto né classe sociale, ma spesso ha le chiavi di casa e si ripete nei tribunali e nelle istituzioni, fenomeno trasversale rispetto a ceto sociale di appartenenza, livello di istruzione e background culturale.
Come si manifesta?
Un altro assioma da scardinare è la convinzione che la violenza sia esclusivamente il maltrattamento fisico o l’abuso sessuale; infatti la maggior parte degli episodi di violenza esercitate ai danni delle donne colpiscono ed umiliano la vittima sul piano psicologico; le dinamiche della violenza includono così l’isolamento sociale, la privazione economica, il controllo e la sopraffazione. Possiamo definire quindi la violenza di genere come ogni forma di abuso fisico, psicologico, normativo e giuridico che impedisce alle donne di godere degli stessi diritti degli uomini; la coercizione e la discriminazione che producono l’annientamento psicologico della vittima e la negazione dell’esistenza stessa della donna.

Sia che si tratti di maltrattamento fisico che di violenza a carattere simbolico per affrontare in modo determinante la questione rivolgendo uno sguardo agli strumenti da compiere per fronteggiare il problema è necessario mettere in evidenza i più profondi sottili ed infidi meccanismi che stanno alla base di ogni tipo di violenza. Se è da intendersi violento qualsiasi atteggiamento che genera forme di dominazione, discriminazione e pregiudizio contro le donne, dobbiamo andare alla ricerca ed indagine di quel substrato simbolico che in modo inconsapevole agisce e definisce i modelli sociali che ne diventano espressione. La violenza simbolica presente nei processi linguistici ed iconografici viene inconsapevolmente interiorizzata sia dagli uomini che dalle donne e questo spiega il perpetrarsi di modelli stereotipati e vincolanti.
Se pensiamo al secolare dominio maschile sulle donne, alle forme più severe del patriarcato, ci accorgeremo che alcuni aspetti alimentano tutt’oggi l’immaginario sul femminile rappresentando, in parte, l’attuale condanna della donna la cui definizione rimane ancorata ai soli ruoli sociali e funzionali, come per esempio quello di moglie o “focolare della casa”, o alla sola essenza biologica (la donna-madre), impedendo la possibilità che le venga riconosciuto l’universo di cui essa è portatrice.
Ecco, ad esempio, la testimonianza su www.lastampa.it del 24/11/2019, di un uomo ad oggi in cura presso uno psicoterapeuta:
Sono un uomo che maltratta le donne. La mia compagna se ne è andata insieme alla bambina che abbiano avuto. Non ce la faceva più a stare con me. Non mi ha salutato. Ha sbattuto la porta e se ne è andata. Io non ho capito all’inizio, e pensavo che fosse solo una stronzetta viziata, incapace di tollerare gli alti e bassi della convivenza. E i miei amici mi davano ragione. «Dimenticala» mi dicevano. «Sicuramente ha un altro». E la gelosia montava come la rabbia e la voglia di andare a riprendermi quello che ritenevo una mia proprietà, un mio diritto. Le ho fatto scenate, le ho sgarrato le gomme della macchina, le ho fatto le poste. Non le ho mai messo le mani addosso. Questo no, nemmeno quando stavamo insieme. Ma so che se non avessi chiesto aiuto è lì che sarei arrivato. C’è mancato poco. Devo dire grazie a mia madre se oggi sono guarito, o almeno in convalescenza. Quando le raccontavo del mio dolore, dell’abbandono, del mio stupore per quello che era successo lei con grande fermezza e dolcezza mi ha fatto capire che ero io dalla parte sbagliata. E mi ha chiesto un favore: «Ti prego vieni con me, solo una volta da uno psicoterapeuta esperto in problemi di gestione della rabbia». Io non mi sentivo «malato», ma lo ero. E ho deciso di provare. «Vedrai, mi dicevo, che anche questo medico mi dirà che non ho niente che non va».
È un percorso lungo, ancora in corso, ma oggi sono consapevole che i mostri non sono solo gli uomini che uccidono e massacrano di botte le loro donne, ma anche quelli come me che le umiliano e cercano di esercitare su di loro un potere assoluto. Io controllavo la mia compagna, e quando arrivava in ritardo le facevo scenate violente per poi chiederle scusa. Se a una cena lei parlava con un altro, anche solo il suo vicino a tavola, quando uscivamo le scaricavo addosso tutta la mia gelosia. Volevo avere le password del telefono e del computer. Non la facevo mai andare a cena con le amiche, se non eccezionalmente. Detestavo che lavorasse e ho cercato di umiliarla in tutti modi perché volevo che si occupasse solo di me. Godevo nel farla sentire una nullità. Perché doveva riflettersi in me. Ormai l’ho persa. Ma spero di avere ritrovato me stesso.
A differenza di quanto sopra, solitamente una donna vittima di violenza entra in un vortice, una vera e propria escalation che si nutre dei sensi di colpa e di responsabilità del sopruso subito e che la porta al convincimento di esserselo meritato. Vittima finanche di atteggiamenti di disprezzo, queste donne vedono insediarsi la violenza nella propria identità giungendo a sperimentare un atteggiamento di autosvalutazione, abbassamenti radicali dell’autostima e profondi disagi al quale spesso non riescono a dare un nome. Le strutture sociali, le istituzioni ed il complesso dei valori collettivi, come visto influenzati da un inconsapevole processo che da sotto le influenza, non sono capaci di sostenere le vittime.
Troppo spesso abbiamo sentito le più brutali affermazioni su “l’esserselo andata a cercare” o tristi e basse considerazioni sul modo di atteggiarsi o vestire. Una coscienza vuota quindi ancora una volta violenta ed incapace di comprendere la portata ideologica del linguaggio e delle immagini dagli effetti individuali e microsociologici. Come poterne prendere le distanze se invisibile, simbolico, inconsapevole? Come poter centrare un intervento sul fenomeno che non si limiti all’indifferente pietà o alla superficiale compassione? Come riuscire a dar voce a quel dolore di chi non può risalire dal vortice profondo in cui è stato trascinato? La violenza figlia di un pensiero assente incapace di riflettere su sé stesso e quindi di diventare consapevole impone uno stratagemma cognitivo. Una ricerca del significato profondo, la consapevolezza di tutto il sommerso, dell’invisibile.

Questo strumento è forse il solo che permetterebbe l’effettivo sradicamento della violenza ai danni delle donne perché se da un lato incrementa la vigilanza e la comprensione dei condizionamenti invisibili, dall’altro si opporrebbe alle derive violente, scoraggiando non più la vittima ma il carnefice. La violenza veicolata subdolamente dai media, dalle pubblicità e oggi anche da quelle forme di comunicazione veloci e sempre meno empatiche tipiche dei social media è difficile, se non improbabile, che possa essere consapevolmente osservate dal soggetto specialmente quando non sente di esserne coinvolto.
Le stesse diventano invece tragiche angoscianti ed insopportabili quando lo spettatore si identifica con il protagonista della violenza ed è questo un altro divario su cui è necessario agire per ridurre la distanza con l’altro. Tanto più la vittima di violenza è da noi lontana, nel tempo e nello spazio, tanto più viviamo l’indifferenza e l’estraneità da un’emozione estremamente dolorosa e sofferente.
Ciò che non muove compassione ed attenzione è per noi poco attraente ed interessante.
Compassione e pietà non sono tuttavia bastevoli per risolvere quel senso di lontananza dalla vittima ed il distacco emotivo nei suoi confronti. È necessario affrontare apertamente la responsabilità da parte delle istituzioni e del mondo politico che devono impegnarsi a mettere in atto strategie concrete e monitorabili che intervengano al contempo sul piano soggettivo e collettivo.