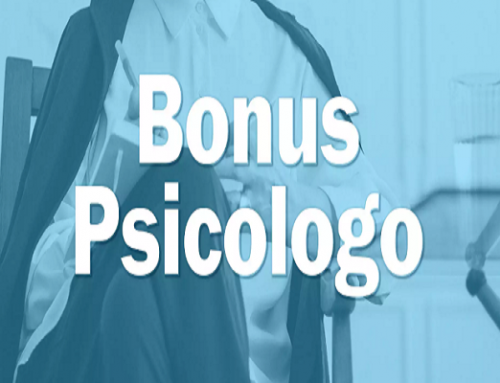L’uomo è un animale sociale per sua natura (Aristotele), tanto che la qualità di vita di una persona si misura anche attraverso le relazioni che è in grado d’instaurare e mantenere, e che vanno a costituire la sua rete affettiva e sociale. Quella che s’instaura tra paziente e terapeuta è un tipo di relazione particolare che costituisce un ingrediente fondamentale per promuovere il cambiamento. Nei termini comuni quando si parla della relazione terapeutica che si viene a creare tra lo specialista e il paziente, si attira spesso l’attenzione sull’importanza dell’empatia, intesa come una condizione fondamentale che dovrebbe stare alla base di un autentico rapporto psicologo-paziente, personale sanitario-malato in generale.
Tuttavia, questa nozione resta vaga e ambigua, dato che da un lato può essere intesa come un invito a trattare il malato con umanità, cosa di per sé lodevole e di mero buon senso, e dall’altro allude al fatto che la relazione di cura sarebbe caratterizzata dal principio secondo cui per entrare in relazione con il paziente è necessario sentire ciò che lui sente. Proprio questa capacità dovrebbe stare alla base della clinica e della cura.
Benché questa seconda accezione sembri necessaria per umanizzare la pratica medica, essa potrebbe tuttavia non essere né ovvia né consigliabile, dato che un’infermiera che assorbe la depressione di un malato terminale forse non si viene a trovare nelle migliori condizioni possibili per svolgere una funzione di aiuto, facendo sì che questa empatia potrebbe addirittura danneggiare la relazione di cura. In altri casi si potrebbe perfino affermare che l’empatia può produrre un’evidente “inerzia clinica”: per esempio, se un paziente cardiologico esprime la convinzione secondo cui il fumo rappresenta un piacere fondamentale il medico potrebbe, sulla base delle prime riflessioni, vedere i rischi a lungo termine, e tuttavia, sulla base dell’empatia, entrare in uno stato di indecisione relativamente a che cosa sia meglio per il paziente, dunque essere condotto verso questo blocco operativo (Costa, 2019).
D’altra parte, la necessità di forme di interazione più “calde” con il paziente ha una giustificazione storica, in quanto si contrappone a un modello medico che, specie in passato, propendeva per un atteggiamento distaccato, oggettivo, e considerava il coinvolgimento affettivo un pericolo in vista del conseguimento di una prospettiva di cura obiettiva, quindi efficace. Se sì guarda a questa storia della pratica medica, allora una certa enfasi sull’empatia diviene comprensibile, perché ha avuto il merito di indicare l’esigenza di umanizzare le relazioni di cura, attirando l’attenzione sul fatto che nella pratica medica ci si relaziona ad esseri umani.
COS’E’ L’EMPATIA?
Risulta opportuno sciogliere dei dubbi, o meglio, degli equivoci sul termine empatia: la parola è un neologismo, che sostituisce il termine enteropatia foggiato da Husserl che ha radice greca e richiama al soffrire-dentro. Il termine empatia fu coniato da Edith Stein, allieva di Husserl, che definisce precisamente l’empatia con il termine tedesco Einfühlung (sentire ‘patico’ – Fühlung), ossia lo sforzo che compie un individuo nel percepire l’esperienza soggettiva di un’altra persona. Un “sentirsi nei panni di un altro” (Leoni, 2013).
In ogni caso ciò che significhi esattamente empatia è tutt’altro che chiaro, e dentro questa ambiguità si annida un grande pericolo, poiché si rischia di fraintendere il senso della relazione di cura. Per empatia si può quindi intendere una sorta di istinto, una capacità di risuonare con l’altro in virtù di una dotazione istintuale: per esempio, vedendo soffrire un altro, qualcosa risuona in noi, sentiamo il suo dolore, soffriamo con lui e per lui, sentiamo quel che l’altro sente, e proprio questo ci permetterebbe di essergli vicino. Una seconda prospettiva consiste invece nel pensare l’empatia come una sorta di riattivazione di ricordi e di situazioni precedentemente vissute. Così, per esempio, comprendiamo il dolore di un altro perché esso ci ricorda, e riattiva, il dolore che abbiamo a nostra volta un tempo vissuto in prima persona; in questo caso, empatizzare significa proiettare sull’altro ciò che abbiamo vissuto noi in una precedente occasione (Levine, 2010).
Rispetto a questi due modi di vedere le cose bisogna notare che sono tutt’altro che ovvi oltre che, probabilmente, poco realistici. In primo luogo, faremmo male a pensare che comprendere l’altro significhi sentire quel che egli sente: per esempio, se un individuo è arrabbiato con me, Io comprendo che lui è arrabbiato, “sento” la sua ira, ma io non lo sono, tantomeno lo divento. In alcuni casi forse potrei sentire paura davanti a quelle sensazioni.
In secondo luogo, se inizio a sentire rabbia questo non significa che sento la sua o che in generale sento quello che sente lui, ma piuttosto sto iniziando ad arrabbiarmi, sento la mia rabbia, il mio problema diviene non tanto quello di rapportarmi alla sua ira, quanto contenere la mia. Ancora, potremmo anche ipotizzare di sentire la paura o la rabbia di qualcuno, se caso mai potesse succedere davvero, ma l’essere contagiato dalla paura dell’altro impedirebbe a qualsiasi specialista di comprenderlo, di essergli d’aiuto, in generale di essere con lui, poiché quell’emozione proietterebbe piuttosto dentro sé stesso, perdendo di vista il perché di quella emozione nell’altro, “perdendo di vista l’altro”.
Il concetto più vicino a quello dell’effettiva veridicità delle cose, suggerito ad esempio dalle esperienze in riabilitazione, consiste nel fatto che lo specialista può comprendere il malato solo perché vivono nello stesso mondo, anche se parallelo. Si può comprendere il sentirsi emotivamente situato del malato, la sua ansia o la sua depressione perché comprendiamo, nel corso della relazione, le possibilità che l’esistenza gli ha sottratto. Possiamo comprendere un anziano che rifiuta di alzarsi dal letto perché comprendiamo il suo esser-nel-mondo dopo la morte della moglie, comprendiamo lo svanire dell’avvenire, ed è chiaro che la cura in senso autentico deve partire da questo specifico essere nel mondo. Se uno psicoterapeuta non sapesse In quale mondo si trova ad abitare il malato, non potrebbe neanche progettare quale cammino egli deve fare e dove si può andare insieme.
LA RELAZIONE CHE CURA
Emerge così che il termine empatia, applicato alla relazione di cura, può essere molto ambiguo e anche fuorviante, ma niente vieta di utilizzarlo, se si capisce bene come farlo. Quello che è importante è che la relazione di cura venga intesa come un essere insieme nel mondo in vista di qualcosa, una relazione triadica, io-mondo-tu, poiché io e te siamo insieme quando ci incontriamo nel mondo esplicitando possibilità e ponendoci scopi comuni. Solo in questo caso la relazione che cura consiste nel comprendere la malattia e la sofferenza.
Non si tratta, dunque, di sentire quello che sente l’altro, ma di comprendere il suo essere-nel-mondo, cioè quali orizzonti e propositi quella sofferenza ha fatto crollare, o quali lo erano già per arrivare alla manifestazione di quella condizione, e quali possibilità motivano ancora il paziente, poiché la terapia è su questi che fa leva, con il coinvolgimento emotivo che gioca un ruolo importante nell’aderenza alla terapia (Costa, 2019).
Riferimenti
Costa V., Cesana L., 2019. La fenomenologia della cura medica. Corpo, Malattia e riabilitazione. Scholé. Brescia.
Leoni F., 2013. La fenomenologia come esercizio. Postfazione in Calvi L., (2013) La coscienza paziente. Roma.
Levine P.A., 2010. In an Unspoken Voice. How the body Releases Trauma and Restores Goodness. North Atlantic Books, Berkeley (California).