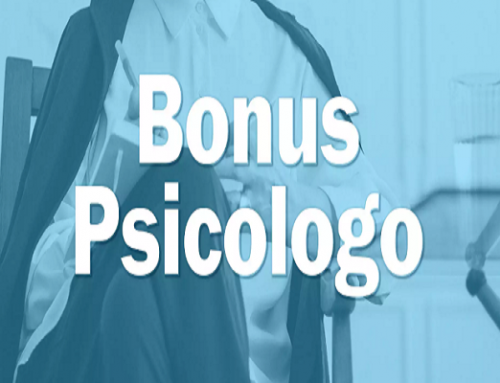Riflessioni al supermarket
Tra uno scaffale di dolci e l’altro, a un metro di distanza gli uni dagli altri, notavo come tra noi in questi complicati giorni, gli sguardi si evitano, i sorrisi si sotterrano, le teste inclinano, le mani nascondono, i passi tentennano. Il vicino di casa, quello che sorride a tutti ogni mattina, smette di farlo. Il conoscente smette di sentirsi e sentire l’altro tale. Nessuno più parla alla cassiera di fiducia e la cassiera a nessuno parla più di fiducia. Al reparto frutta i guanti vestono mani e significati diversi. Le porte che si aprono e chiudono allertano sguardi incappucciati, non per intravedere l’eventuale conoscente del giorno, ma monitorare i movimenti dei profili dell’altro, un sempre nuovo estraneo.
La paura fa parlare i nostri corpi per noi. Corpi scoscesi, corpi che “mettono la freccia”, corpi dietro sciarpe e mascherine di trincea. Corpi vitali dietro corazze armate di occhi radar. Corpi che rilevano le aperture delle forme dei corpi degli altri, corpi che confondono il nemico con l’altro.
Siamo italiani. Parliamo con le mani, ci salutiamo baciandoci, ci emozioniamo toccandoci. Siamo il popolo del corpo a corpo, di quelli che si salutano con uno starnuto (il “Salute!” di derivazione latina), di quelli con la prossemica sempre troppo stretta secondo gli stranieri. Oggi gli stranieri siamo noi. Stranieri con un nemico comune che abita i nostri stessi corpi e di loro si serve per colpire. Per questo sembriamo, noi che coi corpi più di altri comunichiamo, aver messo le nostre emozioni in trincea. Una trincea di singoli e non di truppe. Una trincea da cui non si guarda più al di là del fronte, ma dentro il proprio stesso fronte.
Diventa allora per noi, popolo di corpi dediti alla pacca sulla spalla, alto il rischio di confondere distanza tra corpi e distanza emotiva. Come se emozionarsi di fronte all’altro esponesse al rischio di contagio. Come se i nostri corpi, nonostante la distanza imposta, siano ancora incollati da quella prossemica a cui siamo culturalmente e visceralmente abituati. Come se la distanza fisica dall’altro diventasse distanza emotiva dall’Altro. Il rischio è quello di confondere emozioni e decreti, sensazioni e misure di precauzione.
Che questo momento ci insegni a parlare di emozioni. A dirci emozionati, spaventati, esattamente come l’altro. A dar voce alle atmosfere, a ribattezzare una cenestesi. Che ci insegni a toccare e accarezzare con una frase, un tono di voce, a ricreare intercorporeità con la parola. Ad avvicinare l’altro con la potenza del linguaggio. A riappropriarci delle parole come antidoti.