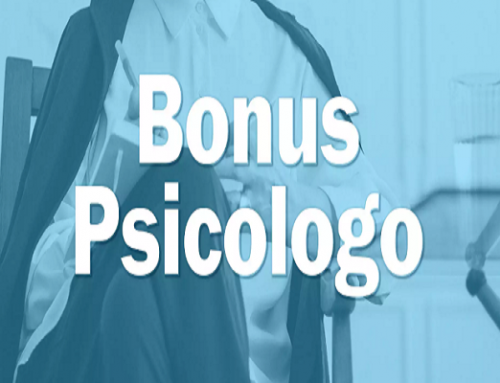Le parole del bellissimo libro «Il seggio vacante» di J.K. Rowlings, descrivono “Cincia” Sukhvinder, un’adolescente figlia di una dottoressa e di un politico, che, di nascosto da tutti, si taglia le braccia con una lametta (Spinelli, 2014).
Secondo l’ultima edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5), sotto la parola autolesionismo (Autolesionismo non suicidario – NSSI, not suicidal self injury), c’è una serie numerosa di comportamenti e condotte attraverso cui provocarsi dei danni a livello fisico con conseguenti sanguinamento, ecchimosi e sperimentazione di sensazioni dolorose. Si parla perciò in letteratura di:
> Cutting: tagliarsi con un oggetto affilato
> Burning: provocarsi bruciature o ustioni
> Branding: marchiarsi con oggetti roventi.
Sebbene i metodi utilizzati talvolta si sovrappongono con quelli tipici dei tentativi di suicidio (p. es., tagliandosi i polsi con una lametta), l’atto autolesionistico non suicidario è distinto dal suicidio perché le persone non intendono il proprio gesto come letale. Infatti, la maggior parte degli individui che pratica queste condotte, può specificamente indicare una assenza di volontà nel renderle tali, o questa la si può dedurre dall’esecuzione ripetuta di metodi chiaramente “non mortali”.
Nonostante la mancanza di letalità immediata, il rischio a lungo termine di tentativi di suicidio è aumentato negli ultimi anni soprattutto negli adolescenti, in base agli studi più recenti (Clayton, 2018; Ougrin, 2012). In generale, i pazienti autolesionisti vanno considerati ad alto rischio di suicidio (Beckman et all, 2018; Olfson et all, 2018;).
Per quanto sia sicuramente una manifestazione di disagio acuto, l’autolesionismo degli adolescenti ha delle caratteristiche proprie. I pazienti spesso si feriscono in una singola sessione, creando lesioni multiple nella stessa posizione, tipicamente in una zona accessibile che comunque tendono a tenere nascosta (p. es., avambracci, cosce ecc.). Il comportamento è spesso ripetuto, con conseguenti ampi schemi di cicatrici.
L’autolesionismo non suicidario tende a manifestarsi nei primi anni dell’adolescenza e la prevalenza è abbastanza uniformemente distribuita tra i sessi; l’anamnesi naturale è chiara, ma il comportamento sembra diminuire dopo l’età giovane adulta. L’autolesionismo non suicidario è spesso associato ad altri disturbi psichici, anche se non obbligatoriamente, in particolare alle manifestazioni del disturbo di personalità borderline, del disturbo antisociale di personalità, dei disturbi alimentari e in quelli di abuso di sostanze.
Perché farsi del male?
Sono molti gli studi che hanno cercato di indagare i perché di queste pratiche. Scrive Strong (2000):
Va detto subito come le condotte autolesionistiche non abbiano un senso univoco, non può esserci una risposta certa e valida in ogni circostanza al perché le persone si auto-danneggiano. Secondo Rossi Monti e D’Agostino (2009) questo fenomeno, un po’ come accade con il suicidio, sembra piuttosto il punto di arrivo di percorsi molto diversi; l’oggettività del dato (un danno sulla pelle) rischia però di farne passare in secondo piano la dimensione soggettiva, ovvero i motivi e i vissuti della persona.
Sicuramente il fatto che una persona si procuri deliberatamente un danno fisico rappresenta una discriminante significativa. L’intenzionalità del gesto è fondamentale. L’autolesionismo, per questo motivo, dovrebbe essere compreso sulla base dei motivi, e non tanto dei risultati. Questo comportamento morboso di auto-aiuto, che tiene il corpo in ostaggio, non implica tuttavia un desiderio di autodistruzione. Bisogna fondamentalmente chiedersi cosa la persona stava cercando di ottenere con quel gesto. La psicopatologia può essere un linguaggio, un linguaggio sostitutivo alla mentalizzazione. Per spiegare meglio cosa accade alla persona che attua queste condotte, partiamo da uno stralcio di colloquio con una paziente, preso da http://nicolaghezzani.altervista.org:

La ragazza è molto esplicita: dapprima racconta di una tristezza di tipo depressivo, che potrebbe spingerla a chiedere contatto affettivo a qualcuno, a cercare un senso della vita fuori dalla sua stanza, dal suo isolamento, o anche indurla a protestare nei confronti del mondo in cui vive. Questa tristezza tuttavia urta contro una barriera di delusione, di mancanza di fiducia in sé e negli altri. Poi, da quel momento, si avvia come per forza d’inerzia la pratica autolesionista: la ricerca del dolore, il bisogno di riconfigurarsi, il desiderio di comunicare, la necessità di regolare le proprie emozioni.
Esaminiamo un po’ questi ultimi aspetti:
• La ricerca del dolore
Fare del male a sé stessi, in queste condizioni, non è considerabile “violenza” pura, ma “quasi un mezzo per farsi del bene” (Valmorbida, 2015). Sul versante neurofisiologico il dolore stimola la produzione di adrenalina. Inoltre c’è qualche evidenza biologica che tagliarsi e bruciarsi possa rilasciare nel cervello oppiacei naturali e altre sostanze chimiche, creando una dipendenza e un ciclo di astinenza. La base biologica della sindrome potrebbe essere connessa con l’azione della serotonina, la quale a sua volta è implicata nell’impulsività (Strong, 2000).
Attraverso la ferita si realizza uno scambio tra psichico e fisico: mente e corpo ritrovano l’unità, anche se in modo ambiguo. L’obiettivo raggiunto in questo modo è quello di evitare che la propria sofferenza sia così diffusa da essere incomprensibile e incontrollabile; la si assicura così in un luogo fisico ben preciso, rendendola visibile sotto forma di un segno sulla pelle.
• Il bisogno di riconfigurarsi
Perdere la sensazione di esistere è peggio che morire: non sentirsi vivi è intollerabile. Ecco perché l’autolesionismo può diventare un processo che dà sollievo, calma e tranquillità. È comunque paradossale che una persona che si sente morta emozionalmente possa avere una emozione così forte da sentirsi sconvolta per questa perdita (Favazza, 2011). Ad ogni modo il dolore autolesionistico ha la forza di far uscire da questo stato, ri-ancorando la persona alla realtà e facendola riappropriare del proprio mondo, soprattutto emotivo.
In ogni ferita, la persona autolesionista preserva sul proprio corpo la storia degli eventi che non ha potuto integrare nel tessuto della sua identità e ciò accade soprattutto in adolescenza. A questa età, la persona autolesionista assume un’identità attraverso il gesto, talmente questo diventa fondante per la sua esistenza. Nascono così i cutters, i wrist-slashers o i burners, che spesso soprattutto nel mondo virtuale, si rivendicano come tali (Gargiulo & Margherita, 2016).
• Il desiderio di comunicare
La violenza può essere un atto comunicativo (ma non sempre lo è). L’autolesionista deve sentire se stesso attraverso il suo stesso corpo. Egli dà origine ad una voce che piuttosto che “vibrare nella sua gola, vibra sulla sua pelle”, la sua stessa carne. Per Merleau-Ponty, dal momento che il linguaggio è un prodotto della nostra esistenza corporea, l’esperienza umana sarà e dovrà essere sempre comunicata: “Fintanto che l’essere umano respira, noi diremo le nostre vite per poter avere o vivere le nostre vite” (1945).
Le parole del fenomenologo francese Merleau-Ponty ci spingono a guardare all’aspetto “comunicativo” dell’autolesionismo in modo del tutto nuovo, superando l’idea di “manipolazione” o di richiesta (cosciente) di attenzione che in alcuni ambienti ancora vige. Tranne che in alcuni casi, l’auto-ferimento è l’esatto opposto di una auto-esibizione intenzionale. Il fatto che l’autolesionista mantenga il segreto sul proprio comportamento, e si sforzi anzi di non mostrare le proprie ferite, basterebbe a sfatare questo mito. È vero comunque che se un danno fisico autoinflitto viene alla luce, esso suscita un tale sgomento e allarme che non può essere ignorato e questo fatto ha un peso enorme nella dinamica interpersonale.
Il ferimento, solitamente ben nascosto, non si ostenta alla visione, perché è rilevante sapere di avere i tagli, ma l’intento non è quello di mostrarli. Sarebbe un comportamento “isterico” se l’autolesione fosse fatta per essere mostrata. Ecco perché possiamo dire, senza contraddizione, che non tutti gli atti autolesionistici sono atti comunicativi, alcuni potrebbero essere risposte a circuito chiuso.
•La necessità di regolare le proprie emozioni
L’autolesionismo può essere vissuto come uno sfogo senza dolore, come un processo auto-calmante, auto-rassicurante, seguito da una sensazione di calma. A volte troviamo l’autolesionismo tra le conseguenze di una rottura o di un litigio: è un modo per liberarsi dalla rabbia e provare a ri-organizzare un Sé frammentato. È sicuramente chiaro che uno dei suoi sensi è quello di espellere via tutte le sensazioni negative: la scarificazione serve per scaricare tutto il dolore, un dolore di cui non si riesce a parlare. Secondo Jeanmet (2001) i comportamenti autolesionisti diventano organizzatori del mondo, gestiscono un’incontrollabile sovraccarico emotivo e tentano di risolvere stati traumatici. Il corpo diviene luogo di emozioni intollerabili, che vanno gestite, controllate.

Le emozioni più comunemente vissute prima del passaggio all’atto sono: rabbia, delusione, freddezza, tensione, senso di incolmabile vuoto interiore, depressione, solitudine, rifiuto, abbandono, impotenza, senso di colpa, sensazioni di estraneità e di alienazione dal proprio corpo, pensieri vittimistici (Garish & Wilson, 2010).
Periodo critico
Il focus di queste condotte sembra essere rintracciabile nella dialettica tra il Sé, il Corpo e il Mondo, proprio come accade in un gran numero di problematiche classicamente riferibili al periodo adolescenziale. Proprio per questo, il corpo adolescente è anche luogo di conflitti: le profonde trasformazioni a cui si va incontro in questo periodo della vita, ne fanno anche il palcoscenico sul quale appaiono le eventuali difficoltà, che in questi casi assumono forme patologiche. Per lo stesso motivo, alcuni pazienti vedono l’autolesionismo come un’attività positiva e quindi tendono a non sollecitare o accettare la consulenza psicologica.
Disturbi alimentari, abuso di sostanze, mancanza di sonno, sono talvolta le manifestazioni più evidenti con cui gli adolescenti si misurano nelle loro prove di crescita. Dietro il sintomo c’è spesso uno stato caratterizzato da povertà di orientamenti e di importanti progetti di vita, una difficoltà ad attribuire significati agli eventi, con il corpo che è, a prescindere, vettore privilegiato di senso e di apertura all’interscambio con il mondo.
Cosa fare?
Dare “un senso al mondo”, donando la possibilità alla persona di riconoscere i propri bisogni e da lì intraprendere una strada verso il futuro, è tendenzialmente l’unica via per dare nuovo slancio alle persone sofferenti, tramite dei percorsi psicoterapeutici ben mirati.
In generale, non è stato approvato nessun farmaco per il trattamento dell’atto autolesionistico non-suicidario. Tuttavia, il naltrexone e alcuni antipsicotici atipici sono stati efficaci in alcuni pazienti (Clayton, 2018). I coesistenti disturbi psichiatrici (p. es., depressione, disturbi alimentari, abuso di sostanze, disturbo di personalità borderline, disturbo antisociale di personalità) devono, inoltre, essere trattati in modo appropriato.
Bibliografia
Beckman, K., Mittendorfer‐Rutz, E., Waern, M., Larsson, H., Runeson, B., Dahlin, M., 2018. Method of self‐harm in adolescents and young adults and risk of subsequent suicide. Journal of Child Psychology & Psychiatry. Vol. 59 Issue 9, p948-956. 9p. DOI: 10.1111/jcpp.12883.
Clayton, P.J., 2018. Autolesionismo non suicidario. University of Minnesota School of Medicine.
Available to https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/disturbi-psichiatrici/comportamento-suicidario-e-atto-autolesionistico/autolesionismo-non-suicidario.
Favazza, A.R., 2011. Bodies Under Siege: Self-Mutilation, Nonsuicidal Self-Injury, and Body Modification in Culture and Psychiatry (3rd edition). Baltimore: Johns Hopkins University Press. (1st edition, 1987; 2nd edition, 1996).
Favazza, A. R., Favazza, B. S. (2011). Bodies under siege: self-mutilation in culture and psychiatry. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Garisch, J.A. and Wilson M.S., 2010. Vulnerabilities to deliberate self-harm among adolescents: The role of alexithymia and victimization. British Journal of Clinical Psychology . 49. 151-163
Gargiulo, A. e Margherita, G., 2016. Ferite nel virtuale: dalla presentazione alla rappresentazione dell’autolesionismo. ResearchGate. DOI: 10.6092/1827-9198/3946
Ghezzani, N. http://nicolaghezzani.altervista.org/psicologia_disturbi_psicologici_psicoterapia-autolesionismo_ed_introversione.html
Jeammet, P. (2001). Innovations en cliniques et psychopathologie de l’adolescence. Annales médico-psychopathologique, Vol. 159, Issue 10, p. 672-678.
Merleau-Ponty, M. (1945).Phénoménologie de la perception. Paris: Gallimard 1979 (tr. it.Fenomenologia della percezione. Milano: Bompiani 2003).
Olfson, M., Wall, M., Shuai Wang; Crystal, S., Bridge, J. A., Shang-Min L., Blanco, C., 2018. Suicide After Deliberate Self-Harm in Adolescents and Young Adults. Pediatrics. Vol. 141 Issue 4, p1-12. 14p. DOI: 10.1542/peds.2017-3517
Ougrin, D.S., 2012. Self-harm in adolescents: the best predictor of death by suicide? – reflections on Hawton et al. (2101). Journal of Child Psychology & Psychiatry. Vol. 53 Issue 12, p1220-1221. 2p. DOI: 0.1111/j.1469-7610.2012.02622.x.
Rossi Monti, M., D’agostino, A., 2009. L’autolesionismo. Roma: Carocci.
Spinelli S., 2014. Advailable to https://silviaspinelli.it/2014/05/05/autolesionismo-non-suicidario-e-psicoterapia-con-gli-adolescenti-la-storia-di-rosa/
Strong, M. 1998. A bright red scream: self-mutilation and the language of pain. New York, N.Y.: Viking; London: Virago 2000. (Tr. it.:Un urlo rosso sangue. Milano: Frassinelli 1999).
Valmorbida, E., 2015. Fenomenologia dell’autolesionismo. La nuova scena del corpo. Centre d’etudes en Psychopathologie et Psychanalyse (CEPP). Available to http://dspace.unive.it/handle/10579/6527